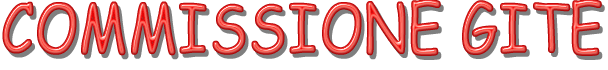

|
|
Orientamento
Una carta è la rappresentazione grafica di una parte della superficie terrestresu un piano. Si tratta dunque della proiezione di una porzione di terreno, fatto anche di montagne e quindi a tre dimensioni, su un supporto che ne ha solamente due. Il tipo di rapporto di riduzione fra la realtà e la carta viene indicato come scala: proprio le cifra della "scala numerica" rappresentano la proporzione fra il terriotorio e la sua rappresentazione cartografica. Le scale vanno da 1:10.000 fino al planisfero, dove si raggiunge la proporzione massima. Fra queste scale, le più utili per l'escursionista e l'alpinista sono quelle da 1:25.000 o 1:50.000 che offrono una rappresentazione di un terriotorio piuttosto limitato, ma con maggior dettagli.
Come accennato prima, sulle carte vengono riportati anche i rilievi, forme a tre dimensioni. Questi sono rappresentati sia con l'aiuto di sfumatore e colori, ma principalmente con le curve di livello, o isoipse. Si tratta di linee immaginarie che uniscono tutti i punti situati a una stessa quota: la prima di queste linee coincide allora con la costa del mare, poi avremo una curva di livello che unisce tutti i punti a quota 100, un'altra a quota 200, e così via. In questo caso diremo che l'equidistanza è di 100 metri. Essa è infatti la differenza di quota tra due isoipse contigue, non la loro distanza. Una volta spiegato il significato di curve di livello è facile immaginarsi il terreno reale guardando le linee di una carta: dove sono più vicine il terreno è più inclinato, al contrario la pendenza diminuisce. La figura sotto semplifica il concetto: si immagina di tagliare una montagna con tante fette orrizzontali dello stesso spessore.
La maggior parte delle carte topografiche non sono pensate per uso esclusivo dell'escursionista, ma per soddisfare delle necessità differenti. In Italia la carta base è quella realizzata dall'Igm, Istituto Geografico Militare, in tavolette che ricoprono tutto il territorio nazionale. Usando come base i rilievi dell'Igm, alcuni editori privati hanno realizzato buone carte a colori, a differenza di quelle militari monocromatiche, che riportano anche strade recenti, sfumature e sentieri. Purtroppo, tranne che in rari casi, i sentieri segnalati sulle mappe non sono frurro di un effettivo sopralluogo. La situazione è migliore al di là del confine, dove la cartografia ufficiale è affidata ad appositi enti statali, che editano le mappe per uso turistico e alpinistico. E' il caso dell'Institu géographique national francese, o dell'Ufficio federale di topografia svizzero.
Per misusare distanze e dislivelli sulle mappe si possono usare sia la scala grafica, riportata nella legenda, che quella numerica con un semplice righellino, un compasso o pezzo di carta. In realtà raramente le distanze sono delle linee rette; negli altri casi si può utilizzare una cordicella, o un morbido fil di ferro, da adattare alle curve dell'itinerario. Per avere un'idea dei dislivelli da superare in un trekking si potrà disegnare un profilo altimetrico del percorso. Per ottenerlo di dovranno prima individuare sulla mappa le quote dei punti più bassi e di quelli più alti e la distanza fra loro; poi si riporteranno tali punti su di un foglio, utilizzando l'asse orrizzontale per le distanze e quello verticale per le quote: unendo tali punti si otterrà una linea spezzata che rappresenta, con molta approssimazione, il profilo altimetrico da affrontare. Bisogna notare che la distanza reale che si percorre su terreni in pendenza è maggiore della distanza planimetrica, cioè quella della carta. In pratica la distanza reale si ottiene applicando il teorema di Pitagora al triangolo formato dalla distanza planimatrica e dal dislivello (i due cateti). Volendo si può anche conoscere la pendenza del terreno su cui ci si muoverà. In tal caso si misura sulla mappa la distanza ed il dislivello e si applica la formula:
pendenza in % = (dislivello in metri x 100) / distanza in metri
La bussola è uno strumento basilare per l’orientamento che, nella sua forma più semplice, è costituita da un ago magnetico poggiato su di un perno e libero di ruotare: per effetto del campo magnetico terrestre si dispone sempre in direzione Nord-Sud, indicando il Nord magnetico. Dato che tutte le carte si basano sul nord geografico, bisogna tenere conto della differenza con quello magnetico, chiamata declinazione magnetica. Essa non è costante, ma cambia nelle differenti parti del pianeta e anche nel corso del tempo: in alcune mappe è segnata la rilevazione effettuata, la data e il cambiamento annuo previsto. Va detto che nel nostro paese tale valore non supera i 2° Ovest, ed è quindi irrilevante ai fini dell’orientamento (rappresenta un errore di circa 90 su un chilometro). Molta più attenzione si dovrà fare alla deviazione magnetica. Dato che l’ago della bussola e sensibile al campo magnetico terrestre, può essere influenzato da qualsiasi altro campo magnetico o elettromagnetico e anche da oggetti che contengono metalli o calamite. Si dovranno effettuare rilevamenti lontano da piloni dell’alta tensione, ma anche da coltellini ed altre calamite.
Fatta questa premessa, bisogna capire quali tipi e che caratteristiche deve avere una bussola per escursionismo. Innanzi tutto deve essere semplice, compatta, leggera e sufficientemente robusta. L’ago non deve oscillare troppo durante il cammino: generalmente il compartimento dove alloggia è stagno e pieno di liquido che stabilizza l’ago, evitando così un’eccessiva oscillazione e quindi una difficile lettura. Molte sono fornite di funzioni complementari che ne aumentano il prezzo ed il peso: bolla di livello, specchio, inclinometro, correzione della declinazione, etc. Anche se nessuna è realmente essenziale, va detto che una bussola goniometrica è estremamente precisa ed utile. Essa è dotata di uno specchio inclinabile e di un mirino, che ne rendono l’utilizzo più complesso, ma che con un po’ di pratica diventa famigliare.
Come utilizzare una bussola? Di fatto con delle buone carte e una discreta conoscenza del territorio la bussola e superflua. Diventa indispensabile quando ci si muove su un terreno sconosciuto o in caso di maltempo. Bisogna dire però che una bussola senza una carta è inutile, solamente l’utilizzo dei due strumenti combinati può essere efficace. Di seguito vedremo delle semplici operazioni, da eseguire sempre in orizzontale, che permetteranno di determinare la posizione sulla carta e di riconoscere il territorio.
La prima operazione da compiere è quella di orientare la carta con la bussola. Per fare questo si deve appoggiare la bussola su di un bordo laterale e ruotare la carta finché l’ago non risulti parallelo al bordo della carta (un errore banale in questo caso è quello di orientare la mappa al contrario, scambiando il nord con il sud).
Una delle operazioni più frequenti è quella di cercare con la bussola un elemento del paesaggio circostante. Una volta scelto sulla mappa, si appoggia la bussola sulla mappa, con il bordo più lungo che unisce i due punti (il secondo è costituito dalla nostra posizione) e si fa ruotare la ghiera finché la freccia del nord riportata sulla ghiera non coincida con il nord geografico (quello dell’ago). A questo punto si dovrà far girare lentamente la bussola, tenendola sul palmo della mano, finché l’ago del nord non coincida con il nord della ghiera: a questo punto basterà guardare nella direzione indicata dal mirino (posto nella parte anteriore della bussola) per individuare la cima cercata. Un’indicazione ancora più precisa sarà fornita da una bussola goniometrica: portandola all’altezza dell’occhio e guardando attraverso il mirino, bisogna girare su se stessi finché l’ago visibile nello specchietto non coinciderà con il nord della ghiera.
Il passo successivo è quello di seguire un percorso con la bussola. L'operazione è piuttosto semplice quando c'è il bel tempo, ma è utilissima in caso di nebbia. La cosa migliore per iniziare sarebbe quella di tracciare una o più linee rette fino al punto da raggiungere, seguendo o no il sentiero. Innanzi tutto si deve cercare con la bussola il punto da seguire, in altre parole ripetere quanto scritto nel paragrafo precedente. Al termine bisognerà seguire direzione indicata dal mirino per raggiungere il punto prestabilito. E' in ogni modo meglio segnarsi l'angolo indicato dalla ghiera della bussola: se inavvertitamente si dovesse spostare, si potrà facilmente ripristinare la direzione. Iniziato il cammino si dovrà ogni tanto controllare un elemento del paesaggio o, se questo non fosse possibile, chiedere ad un compagno di posizionarsi davanti a noi di qualche decina di metri in modo da fare da segnavia: basterà indicargli piccoli spostamenti per mantenere la giusta rotta. Per seguire un itinerario con nette svolte, bisognerà ripetere ogni volta lo stesso procedimento, avendo però l'accortezza di determinare la distanza fra i vari punti e contare i passi strada facendo.
L'operazione più utilizzata è senza dubbio quella di determinare il punto in cui ci si trova, in altre parole fare il punto. Si tratta in pratica di determinare la nostra posizione sulla cartina partendo da degli elementi del paesaggio conosciuti (cime, laghi, baite, etc.). In pratica si deve fare per due volte l'operazione inversa alla precedenti (una bussola goniometrica facilita le cose). Puntato il mirino sul primo punto di riferimento si fa girare la ghiera per farla coincidere con l'ago; individuato l'angolo, si posa la bussola sulla carta, con un lato che passa per il toponimo di riferimento e si ruota finché la ghiera del nord non coincida con quello della mappa e si traccia una linea retta. Ripetere l'operazione scegliendo un nuovo punto di riferimento opportunamente angolato rispetto al primo. La nostra posizione è nel punto d'intersezione delle due rette.
Ai tempi odierni orientarsi con la natura non ha più lo stesso significato che aveva in passato: viene fatto più per gioco che per vero bisogno. Un primo aiuto ci viene dato dal sole. Tenendo conto della differenza tra ora legale e solare, ci si mette con le spalle al sole a mezzogiorno e l’ombra indicherà il nord. L’operazione svolta in altri orari non darà la stessa precisione. Un altro metodo valido a qualunque ora si avvale di un orologio, analogico, non digitale, ovviamente. Ponendolo in orizzontale, si punta la lancetta delle ore verso il punto dell’orizzonte posto esattamente alla perpendicolare del sole; il sud sarà sulla bisettrice dell’angolo formato dalla lancetta oraria con la linea delle 12. Il nord sarà ovviamente il prolungamento di tale retta. La vecchia credenza che affida ai muschi e muffe il compito di segnare il nord non è quasi mai veritiera: è più probabile che crescano sul lato più umido e scuro, che non necessariamente coincide con il nord!
Divagando dall’orientamento, esiste un interessante metodo molto pratico e utile per scoprire quante ore di luce ci sono ancora. Si deve stendere il braccio sinistro orizzontalmente di fronte a noi, con il pollice verso l’alto e le altre dita stese e congiunte. Bisogna muovere il braccio, sempre disteso, finché il sole non si posizione nell’angolo formato dal pollice e dal palmo. A questo punto, usando le dita come unità di misura, si conta quante ce ne starebbero fino al punto dell’orizzonte dove si presume scompaia il sole: ogni dito equivale, più o meno, ad un quarto d’ora.
Tramontato il sole, ci serviremo delle stelle e della luna. Come tutti sanno, la Stella Polare indica il nord, ma come trovarla? Essa è l’ultima della costellazione del Piccolo Carro (il Timone), ma può essere individuata anche a partire dall’Orsa Maggiore prolungando di cinque volte la linea che unisce le ultime due stelle del Carro in un settore quasi vuoto. Per la luna ci affidiamo ad un detto popolare; tenendo presente che quella crescente ha la forma di "D", mentre quella calante di "C", ricordiamoci che :"Luna crescente, gobba a ponente, luna calante, gobba a levante".
GPS è la sigla che sta per Global Position System, cioè sistema di posizionamento globale. Il funzionamento è estremamente complesso, ma all’atto pratico si traduce in maniera molto semplice. Sitratta di un ricevitore satellitare che, in base ai dati forniti da un certo numero di satelliti, calcola le coordinate con un’apporissimazione che va dai 20 ai 50 metri. Il numero minimo di satelliti è di 4, tre per la triangolazione ed uno per la quota, ovviamente più se ne usa, più preciso sarà il rilevamento. Nato per uso militare con una rete di 16 satelliti, è ormai diventato un oggetto di comune utilizzo con una configurazione ormai definitiva: 24 sono i satelliti utilizzati(21 in uso e 3 di riserva). Una volta chiarito di cosa si tratta, vediamo anche che caratteristiche deve avere un GPS per escursioni.
Per la scelta si devono tener conto di diversi fattori: peso batteria, consumo, modalità di funzionamento, dati di posizione in coordinate Utm, robustezza e facilità d’uso. Per il peso una persona singola dovrà per forza orientarsi verso macchine leggere, mentre per gruppo diventa mero rilevante; diciamo che in ordine di peso si va dai 250 grammi al chilogrammo. Altrettanto importante è il consumo delle batterie. Generalmente durano dalle 15 alle 24 ore che per una escursione giornaliera sono più che sufficienti, diventano scarse per le lunghe traversate. Presupponendo che si debba comunque accendere l’apparecchio solo quando si fa il punto, bisogna assicurarsi che si possa ricaricare le batterie nei rifugi o punti d’appoggio. Robustezza e impermeabilità sono generalmente di buon livello, prestare particolare attenzione al vano batterie. Molto importante risulta infine il tipo di funzionamento: gli apparecchi più veloci nell’acquisire dati, che consumano quindi meno energia, sono di tipo ad un canale ma con una rapidissima sequenza di collegamento (tecnica di multiplexing), necessitano però di un segnale molto forte. Dove l’intensità non sia sufficiente si può ricorrere a GPS dotati da 4 a 12 canali, uno dedicato per satellite.
![]()